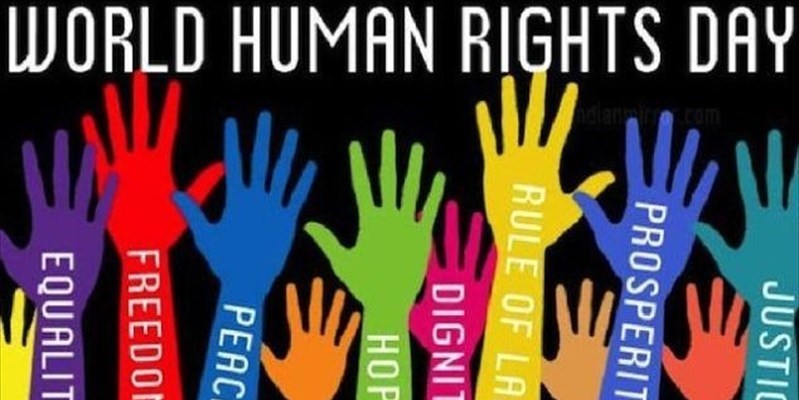Negli anni Settanta del Novecento, sull’onda della mobilitazione studentesca e operaia del ’68-’69 e della mobilitazione femminile, l’Italia visse una stagione di importanti riforme che apportarono significative modifiche nel campo del diritto di famiglia e del diritto civile. Il primo dicembre 1970, infatti, fu approvata la legge sul divorzio conosciuta come “Fortuna-Baslini”, dal nome dei primi due deputati firmatari, Loris Fortuna, socialista, e Antonio Baslini, liberale. Nel 1975 arrivò anche il riconoscimento della parità dei coniugi; cessava così, almeno sul piano legale, il ruolo del maschio capofamiglia. Nel 1978 entrò in vigore la legge che legalizzava l’interruzione volontaria della gravidanza ponendo fine alla piaga degli aborti clandestini.
Queste riforme furono favorite soprattutto dalle lotte condotte dal movimento femminista che, sviluppatosi in tutto il mondo occidentale con varie fasi e caratteristiche, promosse l’emancipazione giuridica, politica e sociale delle donne, con l’intento di eliminare quegli stereotipi che condizionavano la vita della donna nella società e nella famiglia, privandola di un’identità autonoma e relegandola nel ruolo di madre e di moglie.
Quando gli antidivorzisti della Democrazia Cristiana si organizzarono per abrogare la legge sul divorzio con un referendum fissato il 12 maggio 1974, le trasformazioni socio-culturali e la forza del movimento femminista ebbero un peso rilevante nello scongiurare un ritorno al passato: gli italiani, infatti, con il 59,3% di “no”, bocciarono la proposta referendaria, dimostrando che il divorzio era ormai un diritto conquistato.
Lo stesso accadde quando la mobilitazione delle forze progressiste del Paese riuscì a mantenere la legge sull’aborto che, nel 1981, un altro referendum aveva proposto di abrogare.
di Ilaria Lembo